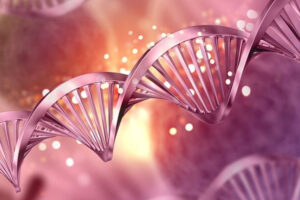Dal 2016 è obbligatorio ricercare nei bambini l’eventuale presenza di 49 patologie: nel mondo, solo gli Stati Uniti fanno di meglio
Quattrocentoventisei neonati, oggi, sono vivi solo per il fatto di essere nati in Italia. Se fossero venuti al mondo in un’altra nazione avrebbero avuto molte meno chance di restare in vita e crescere sani. Il nostro servizio sanitario nazionale, giudicato impreparato per come ha gestito i primi mesi della pandemia di COVID-19, è infatti leader in Europa proprio in un settore che ha a che fare con la prevenzione: lo screening neonatale. Secondo l’ultimo Rapporto SIMMESN (Società Italiana per lo studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo Screening Neonatale), nel 2020 sono stati identificati grazie a questo test ben 426 neonati affetti, uno ogni 1.250 nati.
Un risultato reso possibile dal fatto che da ormai sei anni l’esame è obbligatorio per 49 patologie, mentre negli altri Paesi europei le malattie che è possibile individuare sono molte meno: in alcuni casi, una sola. L’Italia è dunque all’avanguardia nel garantire la salute delle nuove generazioni, ma lo screening neonatale è un tema noto quasi esclusivamente agli addetti ai lavori: non se ne discute nei salotti televisivi, e spesso anche le neo mamme ne sono all’oscuro.
Non è solo un test, ma un vero e proprio processo che inizia presso il centro nascita, prima che il neonato lasci l’ospedale: fra le 48 e le 72 ore di vita viene eseguita una piccola puntura sul tallone del bambino, e alcune gocce di sangue vengono messe a contatto con una speciale carta assorbente. Si ottiene così il campione, chiamato “spot”, che viene poi inviato al laboratorio. Se il risultato del test è positivo, i genitori vengono richiamati dal punto nascita o dal centro screening per eseguire ulteriori accertamenti (esami del sangue, delle urine, test genetici). Nel caso in cui si arrivi alla conferma della diagnosi per una delle patologie sottoposte a screening, si procede immediatamente alla presa in carico del bambino nel Centro clinico di riferimento, per iniziare il trattamento per la specifica patologia, che può essere una terapia farmacologica, dietetica, o anche solo un’attenta sorveglianza.
È di fatto un programma di medicina preventiva, un’indagine a tappeto eseguita su tutta la popolazione neonatale, alla ricerca di bambini che non hanno segni o sintomi di malattia (e che quindi appaiono sani) ma che potrebbero essere affetti da patologie gravissime o potenzialmente letali. Grazie a questo semplice test, gratuito e non invasivo, è possibile identificare precocemente i bambini colpiti da queste condizioni, in modo che – con una terapia adeguata – possano evitare disabilità fisiche e intellettive, e spesso la morte prematura. Si tratta infatti di malattie molto difficili da riconoscere, che degenerano rapidamente ma che per fortuna sono curabili.
Sono tutte malattie rare, ma ciò non significa che i malati siano pochi. Nell’Unione Europea, infatti, una patologia si definisce rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti in una data popolazione, non supera la soglia di 5 casi su 10mila persone. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla fra le 7mila e le 8mila: secondo la rete Orphanet Italia si tratta dunque di circa due milioni di persone nel nostro Paese e addirittura decine di milioni in tutta Europa, nel 70% dei casi pazienti in età pediatrica.
Ormai lo screening neonatale ha più di mezzo secolo: al microbiologo americano Robert Guthrie (1916-1995) va il merito di aver effettuato, alla fine degli anni ’60, il primo screening per una malattia chiamata fenilchetonuria. La sua intuizione fu quella di raccogliere alcune gocce di sangue prelevate dal tallone di un neonato su una particolare carta assorbente, che in suo onore prese il nome di “Guthrie Card”. Oggi il test viene eseguito in molti Paesi del mondo, tuttavia la lista delle patologie ricercate (chiamata “panel”) varia notevolmente, anche in base alle possibilità economiche degli Stati. In Europa il record è proprio dell’Italia, che con 49 malattie previste dal panel è anche la seconda a livello mondiale: solo gli Stati Uniti fanno di meglio, con 62 patologie, di cui 35 principali e 27 secondarie.
Il percorso, nel nostro Paese, iniziò nel 1992, quando venne introdotto lo screening obbligatorio per la fenilchetonuria, la fibrosi cistica e l’ipotiroidismo congenito. Ma la svolta principale è arrivata nel 2016, quando con la legge 167 del 19 agosto lo screening neonatale esteso è diventato obbligatorio per 49 patologie.
Purtroppo, però, oggi questo sistema così virtuoso si è un po’ arenato: negli ultimi sei anni, infatti, non c’è stato alcun adeguamento del panel. Secondo il documento “SNE – Prospettive di estensione del panel”, promosso dall’Osservatorio Malattie Rare, sono almeno sette le patologie che hanno già tutti i requisiti per essere inserite nell’elenco: l’atrofia muscolare spinale (SMA), la sindrome adrenogenitale, la mucopolisaccaridosi di tipo I (MPS I), le immunodeficienze congenite e le malattie di Fabry, di Gaucher e di Pompe. Tutte queste condizioni possono contare su test validati, terapie efficaci ed esperienze di screening svolte in Italia o all’estero: per questi motivi le associazioni dei pazienti e gli specialisti chiedono da tempo di inserirle nel panel nazionale, ma per farlo occorre un decreto di aggiornamento da parte del Ministro della Salute.
Solo così l’Italia potrà conservare il suo ruolo di capofila in Europa, un ruolo reso ancora più importante da una decisione coraggiosa: nel nostro Paese, infatti, lo screening neonatale è obbligatorio, un caso unico in Europa. È un diritto per tutti i nuovi nati, ma anche un dovere per i loro genitori. Fortunatamente, finora, il test è stato accolto con entusiasmo dalla stragrande maggioranza delle coppie e nessuno ha protestato contro quella che di fatto è un’imposizione, ma che è servita a salvare la vita di 426 bambini in un solo anno. D’altra parte, dopo i no vax, l’ultima cosa che ci meritiamo sarebbero i no screening.
Con questo articolo, il nostro redattore Francesco Fuggetta ha superato la 134a sessione dell’Esame di Stato dell’Ordine dei Giornalisti, diventando giornalista professionista.