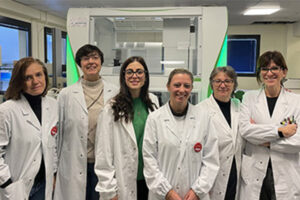I ricercatori americani, però, si mostrano preoccupati per i danni che potrebbe causare: ansia dei genitori, impatto economico sulle famiglie e maggiore utilizzo di procedure invasive
Salt Lake City (USA) – L’atresia biliare è una colangiopatia ostruttiva neonatale che porta a insufficienza epatica ed è la principale indicazione per il trapianto di fegato nei bambini. Senza un intervento chirurgico chiamato epatoportoenterostomia di Kasai (HPE), la malattia è fatale. L’obiettivo di questa sofisticata procedura è creare un collegamento tra fegato e intestino tenue per supplire alle vie naturali – ormai irrecuperabili – che consentono il deflusso della bile.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l’HPE è un intervento palliativo: circa il 50% dei bambini richiederà un trapianto di fegato entro i due anni di età e oltre il 75% ne avrà bisogno nei primi due decenni di vita. Sebbene diversi fattori siano associati a una prognosi migliore, l’unico ad essere modificabile è l’età al momento dell’HPE: i risultati più ottimali si ottengono se l’intervento avviene prima dei 30-45 giorni di vita. L’età media in cui viene diagnosticata l’atresia biliare, però, è di circa 60 giorni e nel corso degli anni è rimasta sostanzialmente invariata.
LO STUDIO DI FATTIBILITÀ
Non sono disponibili tecniche di spettrometria di massa per identificare l’atresia biliare insieme ad altri disturbi neonatali, ma diversi studi hanno dimostrato che tutti i neonati affetti hanno elevati livelli di bilirubina diretta o bilirubina coniugata alla nascita. Un team di medici dell’Università dello Utah ha quindi messo a punto una strategia di screening neonatale in due fasi, che ha misurato i livelli di bilirubina alla nascita e di nuovo dopo due settimane: il metodo ha dimostrato di poter ridurre il ritardo diagnostico e migliorare gli esiti a lungo termine. Lo studio, i cui risultati sono stati recentemente pubblicati sul Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, ha valutato questo metodo per un periodo di 15 mesi in un sistema sanitario integrato (quattro ospedali nello Stato dello Utah), ritenendolo fattibile.
I medici hanno misurato i livelli di bilirubina diretta in un totale di 12.055 neonati sani, poco dopo la nascita. Novantaquattro di loro hanno mostrato livelli elevati, e novanta sono stati sottoposti a un secondo test, due settimane dopo. Quindici neonati (lo 0,12%) sono risultati positivi anche a questo esame e sono stati seguiti con il sospetto di una malattia epatica colestatica. Nessun caso di atresia biliare è stato identificato tramite screening, anche se – successivamente – a due neonati è stata diagnosticata la malattia: questi bambini, pur essendo nati in uno degli ospedali che partecipavano allo studio, non si sono sottoposti al test perché sono stati ricoverati nell’unità di terapia intensiva neonatale, e hanno quindi soddisfatto uno dei criteri di esclusione.
I DUBBI DEI RICERCATORI
Nonostante i ricercatori americani abbiano dimostrato la fattibilità di un programma di screening neonatale per l’atresia biliare, si mostrano preoccupati per i danni che potrebbe causare: una maggiore ansia dei genitori, un impatto economico sulle famiglie e un maggiore utilizzo di procedure invasive. “Due di noi erano responsabili della comunicazione dei risultati anomali alle famiglie”, raccontano gli autori. “In alcuni casi, c’era nei genitori un’ansia evidente, e alcune famiglie avevano il timore che il loro neonato avrebbe avuto bisogno di un trapianto di fegato. Quest’ansia, già segnalata nei programmi di screening della fibrosi cistica, è stata poi mitigata quando abbiamo comunicato e coordinato un rapido follow-up dei risultati positivi”, spiegano gli studiosi.
“L’ultimo ambito di danno è il potenziale uso eccessivo di procedure diagnostiche invasive come la biopsia epatica o il colangiogramma, dato l’alto tasso di falsi positivi con l’utilizzo della bilirubina diretta come strumento di screening”, concludono. “I progressi nei test genetici, una migliore comprensione della storia naturale dell’iperbilirubinemia diretta nei neonati e nuovi test diagnostici potrebbero ridurre la necessità di procedure invasive nella diagnosi di questa malattia”.
LA SITUAZIONE IN ITALIA
In Italia si può affrontare questa patologia nel modo migliore: dal 2011 tutti i casi vengono annotati in un registro nazionale, e dal 2018, grazie all’attività del Network Italiano SIGENP (Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica) per lo studio dell’atresia delle vie biliari, esiste la possibilità di coordinare i 13 centri di alta specializzazione esistenti e di raccogliere dati sui pazienti affetti.
Tuttavia, rispetto agli altri Paesi europei, la percentuale di guarigione, o più correttamente di sopravvivenza con fegato nativo a cinque anni, è inferiore. Lo rivela uno studio compiuto da un gruppo di ricerca del network. Si tratta di un’analisi retrospettiva su 254 casi italiani diagnosticati e trattati nell’arco di dieci anni, dal 2011 al 2021: la sopravvivenza a cinque anni con fegato nativo dei pazienti curati con la procedura di Kasai nei Paesi Scandinavi è stata del 55%, in Inghilterra del 51,3%, nei Paesi Bassi del 46%, in Francia del 41,2% e in Svizzera del 37,4%. In Italia la percentuale è del 35,4%: purtroppo, siamo gli ultimi.