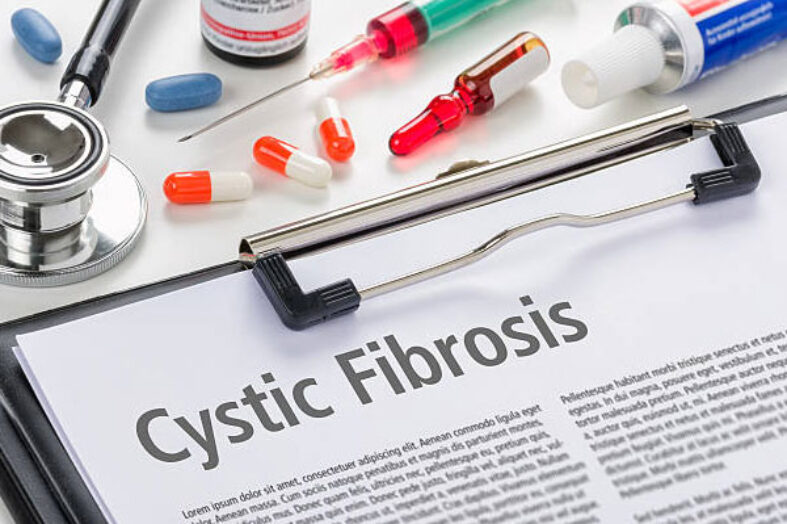Per gli esperti californiani l’unico modo per ottenere questo risultato è adottare un pannello di screening neonatale più ampio
Per uno stato fortemente multietnico come la California è d’obbligo mostrare attenzione alla presenza di diverse razze anche quando si parla di screening neonatale per la fibrosi cistica. I ricercatori americani si sono chiesti se l’adozione di un pannello più esteso, in grado di rilevare un maggior numero di mutazioni, avrebbe portato a un migliore rilevamento della malattia in tutte le razze ed etnie. I risultati sono appena stati pubblicati sulla rivista Pediatric Pulmonology.
La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa: è una patologia multiorgano, che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente. È dovuta a un gene mutato, cioè alterato, chiamato CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator), che determina la produzione di muco eccessivamente denso. Questo muco chiude i bronchi e porta a infezioni respiratorie ripetute, ostruisce il pancreas e impedisce che gli enzimi pancreatici raggiungano l’intestino: di conseguenza i cibi non possono essere digeriti e assimilati. Seppure il grado di coinvolgimento differisca anche notevolmente da persona a persona, la persistenza dell’infezione e dell’infiammazione, che causa il deterioramento progressivo del tessuto polmonare, è la maggior causa di morbilità nei pazienti.
Negli Stati Uniti lo screening neonatale per la fibrosi cistica è universale: i protocolli variano ma includono sempre il dosaggio dei livelli di tripsinogeno immunoreattivo (IRT) e un pannello con un determinato numero di varianti CFTR. In California lo screening avviene in tre fasi: misurazione del livello di IRT, pannello di varianti e sequenziamento del gene CFTR se solo una variante è stata identificata sul pannello.
Gli autori dello studio hanno esaminato una coorte di neonati con fibrosi cistica nati in California fra il 2007 e il 2021, per capire se ci fossero delle differenze razziali ed etniche nell’avere un risultato di screening falso negativo, e in quale fase si fosse verificato. Nello specifico, l’obiettivo era capire in che modo tre diversi pannelli avrebbero potuto migliorare il rilevamento delle varianti in base a razza ed etnia: quello originario da 39 varianti, quello attuale da 75 varianti e uno che riuniva tutte le 402 varianti patogene presenti nel database CFTR2.
Dei 912 neonati con fibrosi cistica nati in California in quegli anni, 84 hanno avuto un risultato falso negativo allo screening (e quindi, in seguito, una reale diagnosi di malattia): 38 a causa di un basso livello di IRT, mentre 46 avevano alti livelli di IRT, ma le mutazioni sono state rilevate in modo incompleto. I neonati asiatici (odds ratio, o rapporto di probabilità, 6,3) e neri (odds ratio 2,5) avevano maggiori probabilità di avere un risultato di screening falso negativo rispetto a quelli bianchi non ispanici.
La maggior parte dei casi di screening falso negativo tra i neonati nativi americani o dell’Alaska e tra i bianchi non ispanici erano dovuti a bassi livelli di IRT, mentre nella maggior parte degli asiatici e degli ispanici non erano state rilevate mutazioni. Con il pannello da 75 varianti, il rilevamento di due mutazioni CFTR è migliorato nei neonati neri, ispanici e bianchi non ispanici; con il pannello da 402 varianti, invece, è migliorato per i neonati neri, ispanici, bianchi non ispanici e di altre razze. Più ampio è il pannello di screening neonatale – concludono dunque i medici – più possibilità ci saranno di individuare la malattia in tutte le razze ed etnie.
In Italia, fin dal 1992, tutti i neonati vengono sottoposti allo screening per la fibrosi cistica. Oggi, per indagare precocemente la presenza della malattia, si utilizza un test basato sul dosaggio della tripsina, un enzima pancreatico. Il dosaggio viene effettuato sulla goccia di sangue prelevata dal tallone del neonato entro le prime 72 ore di vita, la stessa goccia di sangue che si usa anche per indagare le altre patologie ricercate nello screening metabolico esteso.
Se lo screening è negativo, le famiglie non ricevono alcuna comunicazione in merito. Nel caso in cui il test individui livelli elevati di tripsina, la famiglia viene richiamata per effettuare un secondo dosaggio enzimatico, generalmente entro il ventesimo giorno di vita. Se anche questo secondo test conferma il rischio, si procede con test più precisi, come i test genetici che ricercano le più frequenti mutazioni che causano la malattia, insieme ad altri test specifici come il test del sudore. Questo esame, che consiste nel misurare la concentrazione di sale nel sudore, è un test indolore e non invasivo che si esegue in ambulatorio, ed è forse il modo più efficace per diagnosticare la fibrosi cistica.